La comunicazione efficace in RSA: costruire relazioni di fiducia
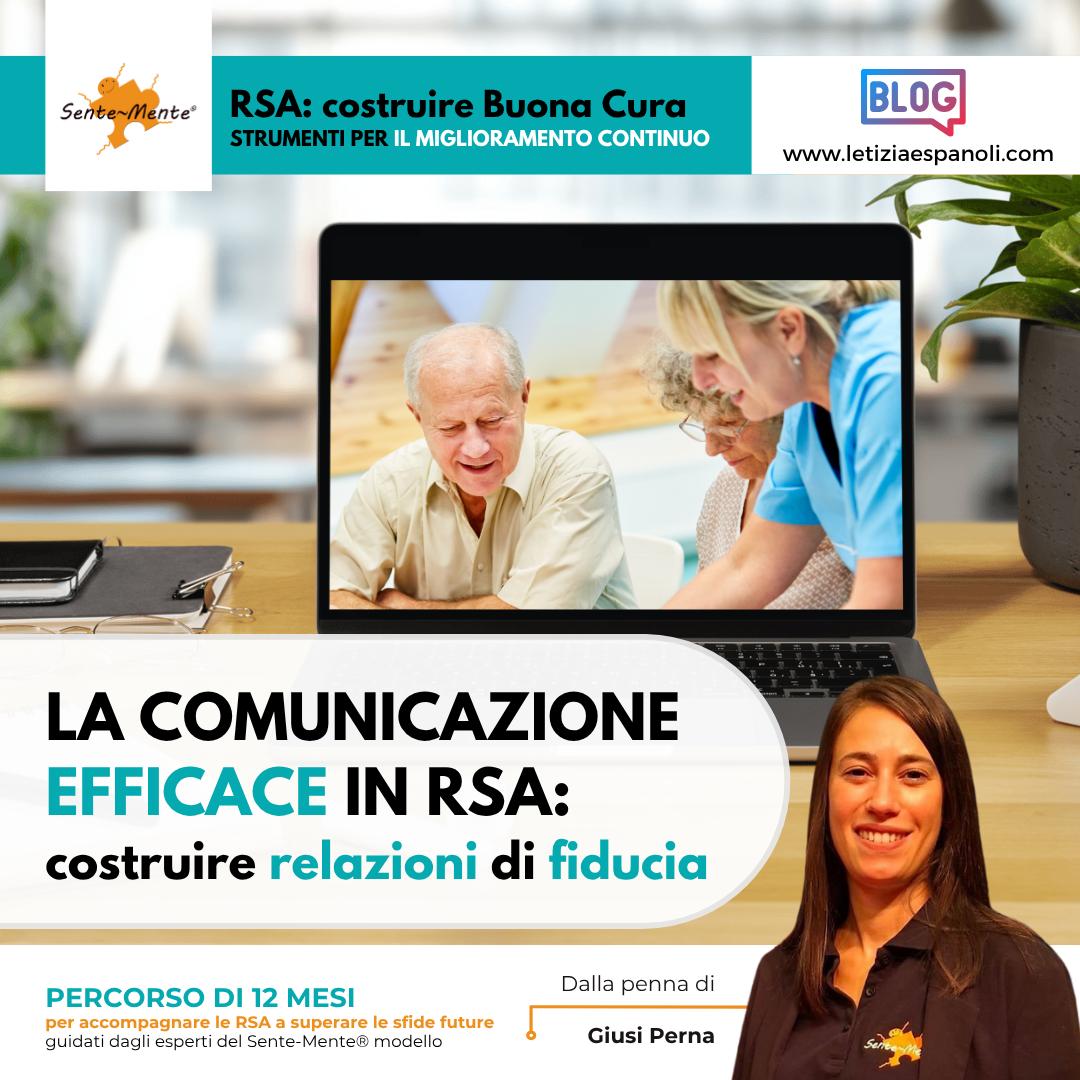
Quando il silenzio pesa più della malattia: il problema della comunicazione nelle RSA
In RSA, la qualità della vita dei residenti non dipende solo dalle cure primarie ricevute, ma anche, e soprattutto, dalla qualità delle relazioni umane. Nonostante ciò, uno dei problemi più sottovalutati in questi contesti è proprio la comunicazione: tra operatori e residenti, tra staff e familiari e all’interno degli stessi team di lavoro.
La comunicazione è alla base di ogni relazione umana, ma spesso, nelle RSA, diventa un elemento fragile, compromesso o addirittura assente. Dove ogni giorno si combattono battaglie invisibili fatte di fragilità, dolore e attesa, la comunicazione dovrebbe essere il primo strumento di cura. La comunicazione, intesa come ascolto autentico, contatto umano, presenza, è uno degli strumenti più potenti nella relazione di cura. Ma è anche uno dei più trascurati e troppo spesso è il primo a mancare.
Familiari faticano a ricevere aggiornamenti chiari, operatori sopraffatti dai carichi di lavoro, residenti che si sentono isolati, incompresi e poco ascoltati: il problema della comunicazione è profondo e diffuso, con conseguenze importanti sul benessere emotivo, fisico e sulla qualità dell’assistenza.
La comunicazione nelle RSA rappresenta una sfida critica che la metodologia Sente-Mente® ha scelto di cogliere: fine ultimo è offrire strumenti utili alla costruzione di un ambiente di cura più umano, trasparente ed empatico. Parlare del problema della comunicazione nelle RSA non è solo un atto di denuncia. È un dovere umano.
In questo articolo esploreremo le principali criticità comunicative nelle RSA, le cause di queste difficoltà e alcune possibili soluzioni che la metodologia Sente-Mente® usa per ristabilire un dialogo autentico e costruttivo tra le figure della triade di cura: residenti, famiglie e personale. Daremo voce a chi spesso non ne ha e rifletteremo su come restituire valore a due parole semplici ma vitali: presenza e cura.
1. Perché la comunicazione può essere inefficace in una RSA: prospettiva scientifica
La comunicazione efficace in una RSA è un elemento cardine per garantire continuità assistenziale, sicurezza e benessere dei residenti. Tuttavia, la letteratura scientifica evidenzia che essa può essere ostacolata da diversi fattori organizzativi e relazionali. Secondo l’OMS (WHO, 2017), errori di comunicazione sono tra le principali cause di eventi avversi in ambito sanitario. In RSA, dove più professionisti si alternano nella gestione dello stesso residente, il rischio aumenta se le informazioni non sono trasmesse in modo chiaro e strutturato.
Uno studio di Jefferies et al. 2012, ha dimostrato che l’assenza di indicazioni chiare rispetto al passaggio consegne porta a omissioni di dati clinici critici, con conseguenze sulla qualità delle cure. La frammentazione dei ruoli e l’elevato turnover del personale amplificano questo rischio. La pressione percepita da operatori e professionisti rispetto al “tempo” è un altro fattore: O’Daniel e Rosenstein, 2008, sottolineano come carichi di lavoro percepiti come elevati riducano la possibilità di comunicazioni approfondite, con il pericolo di trascurare segnali precoci di deterioramento clinico, specialmente nei residenti che convivono con diversi livelli di fragilità o con demenza. In contesti multietnici, barriere linguistiche e culturali possono generare incomprensioni (Almutairi et al., 2015). Inoltre, la componente emotiva, composta da stress, burnout, conflitti, incide sulla disponibilità all’ascolto e sull’efficacia del messaggio trasmesso (Shanafelt et al., 2015).
In sintesi, la comunicazione inefficace in RSA non è frutto di mancanza di volontà ma di un insieme di variabili sistemiche e umane che vanno affrontate con approcci basati su prove scientifiche per garantire sicurezza, qualità e dignità dell’assistenza. Per mitigare tali criticità, le evidenze suggeriscono l’uso di strumenti di comunicazione strutturata, la promozione di momenti di briefing e debriefing, la formazione continua sulle competenze comunicative ed emotive: solidi pilasti della metodologia Sente-mente®.
2. Comunicare è (ancora) avere cura
Immagina un gruppo di residenti, potresti essere tu stesso, tua madre, tuo padre o tuo nonno seduti in una stanza pulita ma silenziosa, circondati da volti che cambiano spesso e parole che non arrivano lì dove c’è bisogno o non arrivano mai davvero. Non è solo la solitudine a fare male, vero? È quel senso di essere dimenticati, fraintesi, non ascoltati.
Nelle RSA, i residenti non chiedono miracoli. Spesso chiedono solo istanti di qualità. Un minuto per raccontare una storia. Per uno sguardo che dica: “Ti vedo”. Una carezza donata con gentilezza, non solo per dovere. Nelle RSA, il tempo sembra diventare un nemico: turni serrati, personale insufficiente, carichi emotivi difficili da gestire. E così, senza volerlo, le parole si fanno rapide, meccaniche, a volte assenti.
Incomprensioni, informazioni parziali o mal gestite e una carenza di ascolto attivo possono compromettere il benessere emotivo delle persone coinvolte. Operatori sotto pressione, familiari lasciati senza risposte e i residenti che si sentono invisibili: così, quello che dovrebbe essere un luogo di accoglienza e dignità rischia di trasformarsi in uno spazio di isolamento emotivo.
Le ricerche parlano chiaro a proposito: la qualità della comunicazione nelle strutture residenziali ha un impatto diretto sul benessere psicologico dei residenti. Uno studio pubblicato sul Journal of Gerontological Nursing (2019) ha evidenziato che una comunicazione empatica e personalizzata riduce i livelli di ansia, depressione e senso di isolamento nei residenti in RSA. Al contrario, interazioni frettolose o impersonali aumentano la percezione di abbandono e inutilità. E non si tratta solo di emozioni.
Il “non detto” può avere conseguenze concrete anche sulla salute fisica dei residenti. Una comunicazione inadeguata può portare, infatti, a fraintendimenti nella gestione del dolore, nella somministrazione delle terapie, nel riconoscimento di nuovi sintomi o nel rispetto della volontà del residente.
3. Comunicare per restituire dignità: il residente al centro
La dignità è riconosciuta dall’OMS come un diritto fondamentale in ogni contesto assistenziale (WHO, 2015) e la comunicazione è uno strumento chiave per mantenerla. Per tale ragione, secondo la metodologia Sente-mente®, comunicare efficacemente non è solo una buona pratica di cura. È un atto di rispetto. Significa riconoscere l’identità del residente, la sua storia, il suo diritto a partecipare alle decisioni che lo riguardano. Peccato che, studi osservazionali (Williams et al., 2009) mostrino che in contesti assistenziali, la comunicazione tenda a diventare meccanica o infantilizzante “elderspeak”, riducendo la percezione di autonomia e dignità. Questo tipo di linguaggio, anche se spesso usato in maniera inconsapevole, può aumentare ansia e resistenza alle cure.
Nel pieno rispetto del modello delle Relazioni di Cura Centrate sulla Persona, la metodologia Sente-mente® mette al centro la comunicazione come un elemento cardine per preservare la dignità e l’identità del residente, anche quando, nella demenza, la memoria vacilla e le parole arrivano a stento.
La letteratura evidenzia, infatti, come il modo in cui parliamo ai residenti influenzi direttamente la loro percezione di sé e sottolinea come l’utilizzo di un linguaggio rispettoso, empatico e personalizzato rafforzi l’identità riducendo i comportamenti speciali e il ritiro sociale.
Le persone con demenza, specialmente nelle fasi avanzate, possono avere difficoltà a comprendere messaggi verbali complessi. Tuttavia, la comunicazione non verbale (contatto visivo, tono di voce, gesti), mantiene un forte potere relazionale (Sabat, 2017). La metodologia Sente-mente® sceglie quindi di integrare in un clima relazionale rispettoso, gentile e autentico, parole semplici e un linguaggio non verbale positivo in grado di favorire fiducia e cooperazione. La ricerca raccomanda la formazione del personale (Fazio et al., 2018) e l’adozione di modelli organizzativi che, come Sente-Mente® organizzazione, valorizzino il tempo dedicato alla relazione e non solo alla prestazione.
4. Comunicare con cura al residente: 10 consigli utili dalla comunità scientifica
1. Parla lentamente e con frasi brevi
→ Le persone con demenza elaborano più lentamente le informazioni. Frasi semplici e chiare migliorano la comprensione (Small et al., 2003).
2. Chiama sempre le persone con demenza per nome o come il residente desidera
→ Usare il nome proprio stimola il riconoscimento e rafforza l’identità personale (Kitwood, 1997).
3. Mantieni il contatto visivo
→ Il contatto visivo trasmette attenzione e fiducia. Aiuta anche a compensare la difficoltà nella comprensione verbale (Sabat, 2017).
4. Evita l’“elderspeak” (linguaggio infantilizzante)
→ Toni eccessivamente dolci o vezzeggiativi possono ridurre l’autostima e aumentare la resistenza all’assistenza (Williams et al., 2009).
5. Lascia il tempo per rispondere
→ Le persone con demenza hanno bisogno di più tempo per elaborare e rispondere. Non interromperle (Alzheimer’s Society, 2022).
6. Sii coerente con tono e linguaggio del corpo
→ La comunicazione non verbale (gesti, espressioni, postura) deve supportare il messaggio verbale. Le incongruenze possono generare confusione (Bourgeois, 2002).
7. Usa domande chiuse, con una sola opzione per volta
→ Le domande semplici (es. “Vuoi bere un tè?”) sono più facili da gestire rispetto a scelte multiple (Kagan, 1998).
8. Ripeti o riformula senza correggere
→ Se non vieni compreso, ripeti o cambia parole senza sottolineare l’errore dell’altro. Mantiene la relazione e il rispetto (Fazio et al., 2018).
9. Respira, sintonizzati sulle tue emozioni e adatta il tuo tono all’umore della persona
→ Sintonizzarsi emotivamente aiuta a calmare l’ansia e promuove il benessere relazionale (Brooker, 2007).
10. Porta sempre con te un sorriso sincero
→ I segnali di linguaggio non verbale affettivi positivi, come il sorriso, rimangono comprensibili anche nelle fasi avanzate della demenza e favoriscono un clima di benessere e sicurezza emotiva (Sabat, 2001).
5. Comunicazione mancante, cuori lontani: il dolore dei familiari
Immagina una scena comune in una RSA: Maria, 85 anni, vive lì da alcuni mesi. La figlia arriva in struttura per una visita settimanale. L’operatore, tra un compito e l’altro, le dà un rapido aggiornamento: “Sta bene, nulla di nuovo.” La figlia chiede un chiarimento sul recente aumento della dose di terapia farmacologica ma riceve risposte affrettate e poco dettagliate. Dopo la visita, resta angosciata e confusa: «Perché nessuno mi ha avvisato e spiegato il motivo del cambiamento?». Questo senso di vuoto e frustrazione non resta isolato.
Un’indagine qualitativa condotta su 103 familiari e circa 450 operatori in strutture geriatriche ha rilevato numerose difficoltà organizzative: sottorganico, alto turnover, routine che non coincidono con le visite dei familiari, scarsa formazione e comunicazione interna inefficace.
Risultato? Incomprensioni, senso di esclusione e lamentele da parte delle famiglie che si sentono spesso trascurate o ignorate. Oltre alle criticità sistemiche esistono differenze emotive, culturali e di ruolo.
Mentre i familiari vivono sensi di colpa, ansia e confusione di ruolo, gli scambi con i professionisti possono apparire loro freddi o autoreferenziali. La dissonanza tra aspettative, valori e capacità reali di comunicazione quindi è fonte di conflitto e incomprensione.
Inoltre 15 RSA italiane è emerso che, mentre lo stress, il burnout o la depressione prevalgono tra i familiari, essi si sentono sempre più confusi e dubbiosi circa i processi di cura. Molti operatori usano una terminologia tecnica non sempre comprensibile; questo genera confusione e può ostacolare la reale comprensione dello stato di salute del residente.
Il fenomeno documentato dell’“elderspeak” viene percepito, anche dal familiare, come degradante e infantilizzante tanto da innescare resistenza alle cure. Inoltre, come accade nei contesti ospedalieri, anche nelle RSA, la comunicazione inefficace accresce il rischio di errori nella cura e nel coordinamento dell’organizzazione.
6. Comunicare con cura alla famiglia: 9 consigli utili dalla comunità scientifica
1. Ascolto attivo
· Mantenere contatto visivo, annuire e riformulare per confermare la comprensione.
· Studi dimostrano che l’ascolto attivo aumenta la fiducia e riduce conflitti (McGilton et al., Gerontologist, 2017).
2. Linguaggio chiaro e privo di linguaggio medico
· Evitare termini troppo tecnici; spiegare in modo semplice e concreto.
· Nilsen et al. (BMC Health Serv Res, 2014) mostrano che questo migliora la comprensione delle decisioni cliniche.
3. Comunicazione regolare e programmata
· Aggiornare i familiari con cadenza definita, non solo in caso di emergenza.
· La comunicazione programmata riduce ansia e reclami (Luoghicura.it, 2018)
4. Coinvolgimento attivo dei familiari
· Includerli nelle riunioni PAI e nella presa di decisioni chiave.
· Favorire la percezione di trasparenza (Welforum.it, 2021).
5. Empatia e validazione emotiva
· Riconoscere le emozioni espresse (“Capisco che questa situazione possa essere difficile”).
· Migliora la relazione e la collaborazione (Suchman et al., JAMA, 1997).
6. Coerenza delle informazioni
· Garantire che tutti i membri del team forniscano lo stesso messaggio.
· Evita confusione e perdita di fiducia (McGilton et al., 2017).
7. Supporti scritti e visivi
· Fornire opuscoli, schemi terapeutici o grafici per facilitare la comprensione.
· Utile specialmente per informazioni complesse (Nilsen et al., 2014).
8. Contatto umano costante
· Un referente stabile per ogni famiglia migliora la continuità relazionale e la soddisfazione (Luoghicura.it, 2018).
9. Formazione continua di operatori e professionisti
· Dimostrato efficace nel ridurre incomprensioni e tensioni (McGilton et al., 2017).
7. Tabella pratica di comunicazione efficace in RSA
|
Consiglio |
Frasi Efficaci |
Frasi da Evitare |
| 1. Ascolto attivo | “Se ho capito bene, lei è preoccupato per la perdita di appetito di sua madre, giusto?” | “Sì sì, ho capito” (senza ripetere o confermare) |
| 2. Linguaggio chiaro | “La pressione di sua madre è un po’ bassa, quindi oggi le daremo più liquidi” | “C’è un’ipotensione sintomatica in atto” |
| 3. Comunicazione programmata | “Ogni lunedì le daremo un aggiornamento telefonico sullo stato di salute” | “Le faremo sapere se c’è qualcosa” |
| 4. Coinvolgimento attivo | “Vorremmo sapere la sua opinione prima di decidere il cambio di terapia” | “Il medico ha già deciso” |
| 5. Empatia | “Capisco che questa situazione possa essere difficile per lei” | “Non si preoccupi, è normale” (minimizza l’emozione) |
| 6. Coerenza informazioni | “Il medico e io le confermiamo che il piano rimane invariato” | “Il medico le ha detto questo? Io non lo sapevo” |
| 7. Supporti visivi | “Ecco il grafico del peso di sua madre, così può vedere l’andamento” | “Sta calando di peso” (senza dati o supporto visivo) |
| 8. Continuità relazionale | “Da oggi sarò io il suo referente per ogni comunicazione” | “Può parlare con chiunque del personale” |
| 9. Formazione continua | “Abbiamo seguito un corso sulla gestione di conversazioni difficili” | “Non è il mio compito comunicare queste cose”
|
La comunicazione non basta: serve un cambio di cultura
Le parole, se pronunciate con attenzione, diventano carezza, rassicurazione, presenza. Creare una comunicazione aperta, costante, empatica e strutturata non è solo buona pratica: è atto d’amore verso chi vive una fase delicata dell’esistenza e verso chi lo ama tanto da aver bisogno di sentire, anche a distanza, un abbraccio rassicurante.
Dietro ogni residente, infatti, c’è una storia. Un amore perduto, una guerra vissuta, un figlio cresciuto con fatica, un sogno realizzato o interrotto. Se impariamo ad ascoltare, a guardare davvero, a trovare le parole, non solo li aiuteremo a sentirsi meno soli: ritroveremo anche noi un pezzo della nostra umanità.
E quando la fragilità è amplificata da condizioni come la demenza, la chiarezza nello scambio di informazioni non è solo un requisito tecnico: è un atto di rispetto verso la persona e la sua storia. E in un mondo che invecchia sempre di più, forse è proprio da qui che dovremmo ripartire: dal coraggio semplice e rivoluzionario di fermarci ad ascoltare. Serve un cambio di paradigma: passare da un’assistenza centrata sul compito a una centrata sulla relazione. Perché in fondo, come scriveva lo psicoterapeuta Viktor Frankl, “l’uomo è un essere che vive di significati”. E nelle RSA, restituire significato alle giornate dei residenti, familiari e operatori è un atto di profonda umanità.
E tu, come vivi la comunicazione con la RSA? Racconta la tua esperienza: la tua storia può diventare fonte di ispirazione per altre famiglie e operatori.
Se sei un operatore, inizia oggi stesso un dialogo nuovo: dedica anche solo dieci minuti in più a una conversazione con un residente e/o familiare. Scegli con cura le parole, potresti scoprire che quelle semplici e sincere, restano impresse più di qualunque procedura. Osserva il linguaggio non verbale, scrigno ricco di significati celati.
APPROFONDIMENTI
- Gocce di cura in RSA. A tu per tu con la demenza: 5 – CON‑TATTO 1 – La magia della cura nella semplicità di uno sguardo
- Per un’organizzazione che cura – Idee e azioni possibili secondo il Sente-mente® modello, Letizia Espanoli – Editrice Dapero, 2020
-
RSA: costruire relazioni di fiducia con le famiglie
-
McGilton, K. S., et al. (2019). Uncovering the rules of communication in long-term care: How staff interact with residents who have dementia. Journal of Gerontological Nursing, 45(1), 9–14.
- Rodríguez-Molinero, A., et al. (2016). Relationship between communication problems and physical/emotional well-being in institutionalized older adults. Archives of Gerontology and Geriatrics, 62, 130–136.




